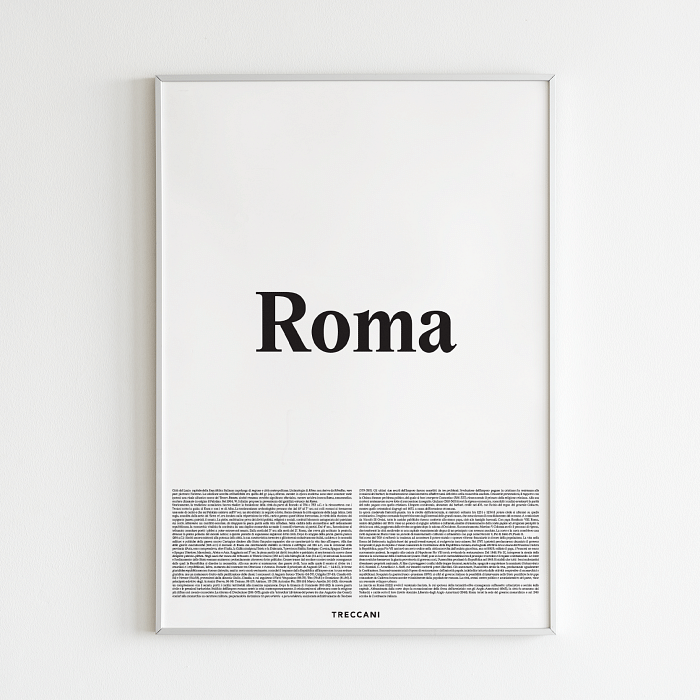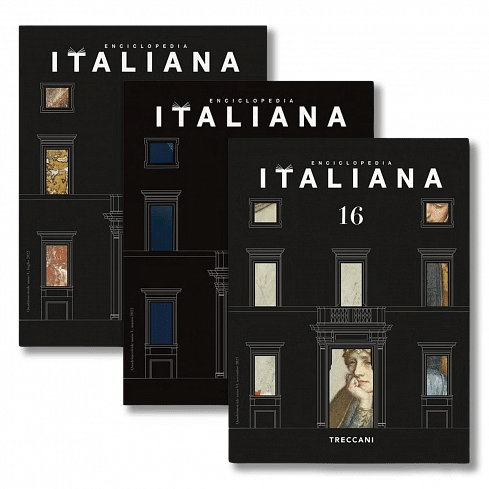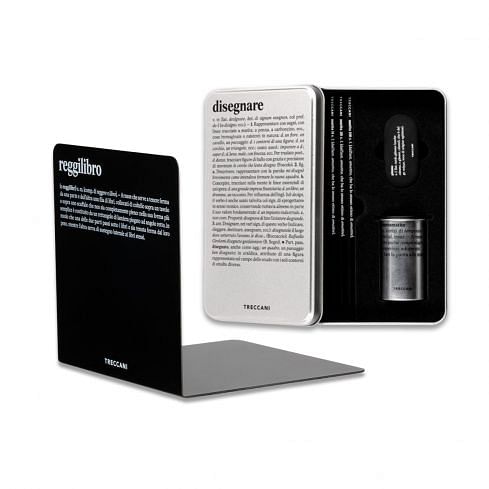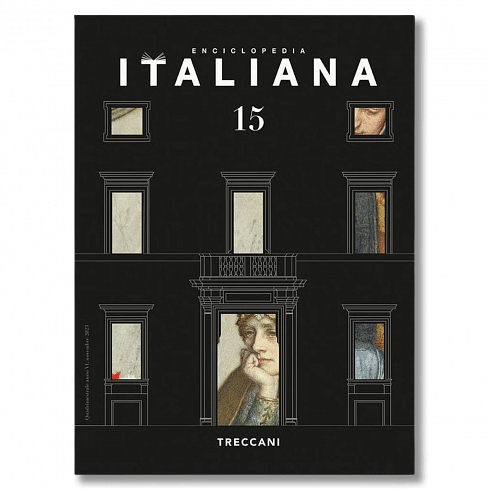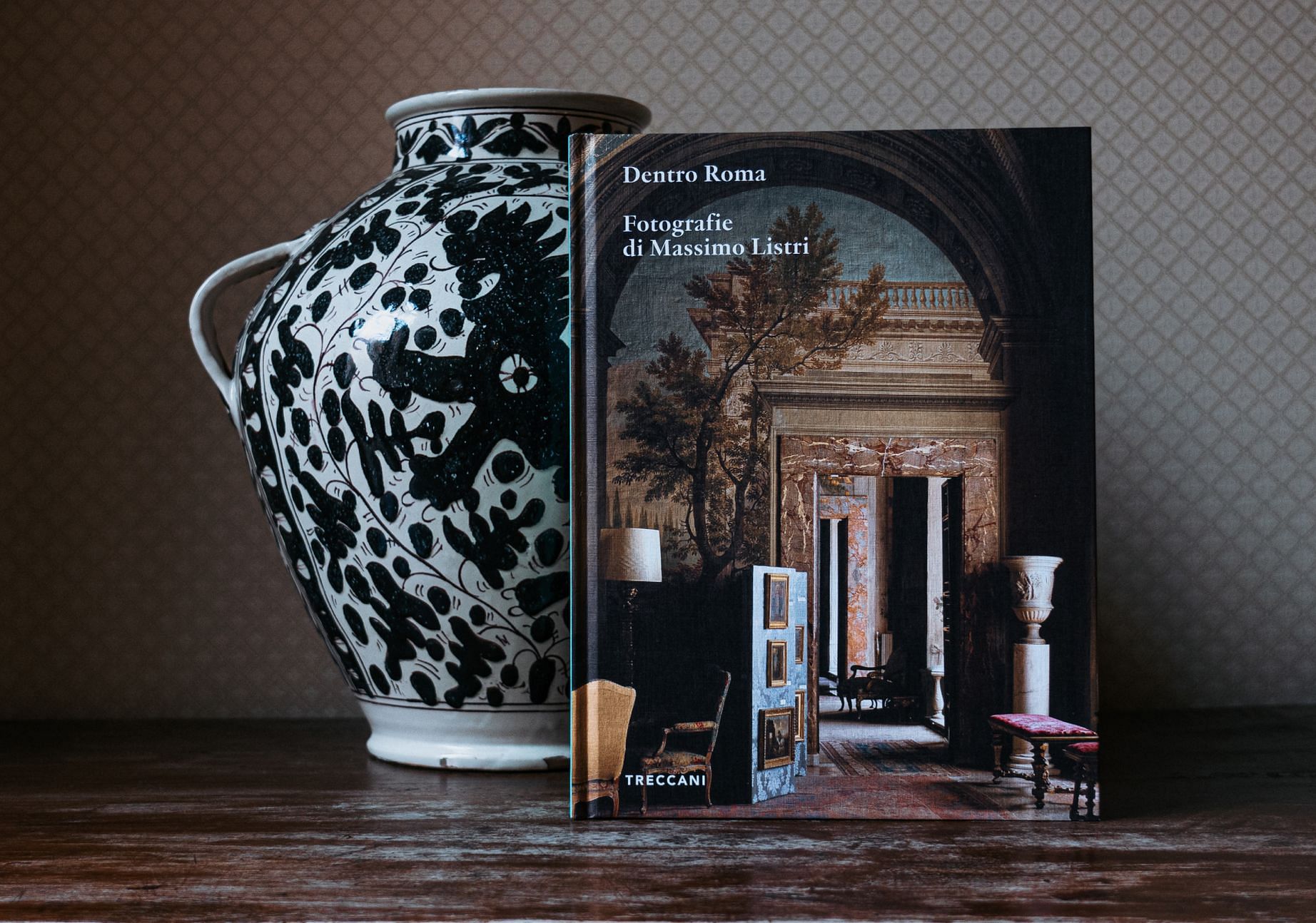Poster - ROMA
Dettagli prodotto
Tipologia Carta: Patinata opaca da 170gr.
Il poster viene venduto senza cornice, per ordini relativi a più di un poster gli stessi verranno spediti in un unico tubo. Nel caso in cui si preferisse ricevere i poster imballati singolarmente è necessario effettuare ordini differenti.
Definizione Poster
Città del Lazio, capitale della Repubblica Italiana; capoluogo di regione e città metropolitana. L’etimologia di Rōma non deriva da Rōmŭlus, vero pare piuttosto l’inverso. La soluzione accolta nell’antichità era quella del gr. ῥώμη «forza», mentre in epoca moderna sono state avanzate varie ipotesi: una risale all’antico nome del Tevere Rūmōn, sicché rōmānus avrebbe significato «fluviale», mentre un’altra invoca Rūma, «mammella», com’era chiamato in origine il Palatino. Nel 1904, W. Schulze propose la provenienza dal gentilizio etrusco dei Ruma.
Storicamente, la tradizione annalistica faceva risalire la fondazione della città da parte di Romolo al 754 o 753 a.C. e la riconnetteva con i Troiani sotto la guida di Enea e con i re di Alba. Le testimonianze archeologiche provano che dal 10° al 7° sec. sui colli romani si formarono una serie di centri e che sul Palatino esisteva nell’8° sec. un sito abitato; in seguito a lotte, Roma divenne la città egemone della Lega latina. L’età regia, scandita dalla serie dei ‘Sette re’, era fondata sulla tripartizione in tribù, curie e gentes; quest’ultime formavano, in virtù della riunione dei capigente (patres, patrizi), il senato. La plebe, moltitudine priva dei diritti politici, religiosi e sociali, costituì l’elemento antagonista del patriziato cui cercò, attraverso un conflitto secolare, di strappare la piena parità nella vita cittadina. Nella caduta della monarchia e nell’ ordinamento repubblicano, la monarchia vitalizia fu sostituita da una duplice monarchia annuale (i consoli) riservata ai patrizi. Dal 4° sec., l’ammissione al tribunato consolare portò i plebei a poter entrare nel senato. Dalla metà del 3° sec. alla metà del 2°, Roma, che aveva già unificato la penisola, divenne la prima potenza del mondo antico; a questo periodo di espansione seguirono lotte civili. Dopo lo scoppio della prima guerra punica (264 a.C.) i limiti ancora esistenti alla potenza della città, la sua caratteristica terrestre e gli interessi esclusivamente italici, caddero, e le necessità militari e politiche della guerra contro Cartagine diedero allo Stato l’impulso espansivo che ne caratterizzò la vita fino all’Impero. Alla fine delle guerre macedoniche (168 a.C.) il dominio di Roma era direttamente stabilito in Grecia e nell’Egeo; nel 126 a.C., con la creazione della provincia d’Asia, esso comprendeva, oltre l’Italia, la Gallia cisalpina, l’Istria e la Dalmazia, 7 province: Sicilia, Sardegna-Corsica, Spagna Citeriore e Spagna Ulteriore, Macedonia, Africa e Asia. Raggiunta nel 3° sec. la piena parità dei diritti tra plebe e patriziato, si era formata la nuova classe dirigente patrizio-plebea. Negli anni che vanno dal tribunato di Tiberio Gracco (133 a.C.) alla battaglia di Azio (31 a.C.), le istituzioni, la società e l’ordinamento dello Stato romano mutarono profondamente attraverso lotte politiche; Cesare trasse dal secolare scontro sociale conseguenze dalle quali la Repubblica si dissolse in monarchia. Alla sua morte si scatenarono due guerre civili, l’una nella quale il senato si divise tra i cesariani e i repubblicani, l’altra, maturata dal contrasto tra Ottaviano e Antonio. Durante il principato di Augusto (27 a.C. – 14 d.C.), le forme giuridiche repubblicane non furono distrutte, anzi in certo modo restaurate, cosicché il trapasso dalla Repubblica all’Impero non fu una rottura giuridica, ma un mutamento frutto della pacificazione delle classi. I successori di Augusto furono Tiberio (14-37), Caligola (37-41), Claudio (41- 54) e Nerone (54-68), provenienti dalla dinastia Giulio-Claudia, a cui seguirono i Flavi: Vespasiano (69-79), Tito (79-81) e Domiziano (81-96). Il principato adottivo degli Antonini (Nerva, 96-98; Traiano, 98-117; Adriano, 117-138; Antonino Pio, 138-161; Marco Aurelio, 161-180), ritrovando un compromesso con il senato, portò i confini territoriali alla massima espansione. Dopo la tirannia di Commodo (180-192), la nuova guerra civile e le pressioni barbariche, l’edificio dell’Impero romano entrò in crisi: contemporaneamente, il cristianesimo si affermava come la religione più diffusa nel mondo conosciuto. La riforma di Diocleziano (284-305), grazie alla ‘tetrarchia’ (divisione del potere tra due Augusti e due Cesari), conferì alla monarchia un carattere militare, preparando la distinzione tra pars orientis e pars occidentis, sanzionata definitivamente da Teodosio (379-395). Gli ultimi due secoli dell’Impero furono assorbiti da tre problemi: l’evoluzione dell’Impero pagano in cristiano; la resistenza alle invasioni dei barbari; la trasformazione amministrativa all’affermarsi definitivo della monarchia assoluta. Cessate le persecuzioni, il rapporto con la Chiesa divenne problema politico, del quale si fece interprete Costantino (306-337), riconoscendo il primato della religione cristiana. Alla sua morte si scatenarono nuove lotte di successione; in seguito, Giuliano (360-363) favorì la ripresa economica, consolidò i confini e restaurò la parità del culto pagano con quello cristiano. L’Impero occidentale, devastato dai barbari, crollò nel 476, con l’inizio del regno del generale Odoacre, mentre quello orientale si disgregò nel 1453, a causa dell’invasione ottomana.
In epoca medievale l’autorità papale, tra le rivolte dell’aristocrazia, si rinforzò; soltanto fra 1231 e 1234 il potere civile si affermò su quello ecclesiastico. Il regime comunale fu però bloccato dagli interessi delle grandi casate, che ostacolavano il consolidamento del comune. A cominciare da Niccolò III Orsini, tutte le cariche pubbliche furono conferite allo stesso papa, cioè alle famiglie baronali. Con papa Bonifacio VIII, Roma, centro del giubileo del 1300, visse un periodo di rigoglio artistico e culturale, mentre il trasferimento della corte papale ad Avignone precipitò la città in una crisi, peggiorata dalle rivolte scoppiate dopo lo scisma d’Occidente. Successivamente, Martino V Colonna avviò il processo di ripresa, che trasformò la città medievale in una capitale rinascimentale degna di un principato con sovrano assoluto. La corte e la curia conobbero una forte espansione; Roma visse un periodo di rinnovamento culturale e urbanistico con papi come Niccolò V, Pio II, Sisto IV, Paolo II.
Nel corso del ‘500 si rafforzò la tendenza ad accentrare il potere statale e operare riforme finanziarie in favore della popolazione. La vita nella Roma del Settecento, tagliata fuori dai grandi eventi europei, si svolgeva in tono minore. Nel 1797, i patrioti proclamarono decaduto il governo temporale; il papa fu espulso e venne consacrata la Costituzione della Repubblica romana, ma la guida effettiva era in mano dei Francesi. Caduta la Repubblica, papa Pio VII assicurò un certo ordine nella città sconvolta dall’ondata giacobina, ma nel 1809, esiliato il papa, i Francesi ne erano nuovamente padroni. In seguito alla caduta di Napoleone Pio VII tornò, avviando la restaurazione. Dal 1846, Pio IX, intraprese la strada della riforma: la concessione della Costituzione (marzo 1848) pose in luce le contraddizioni tra il principio teocratico e il regime costituzionale. Le forze democratiche formarono la giunta provvisoria di governo; così, l’Assemblea proclamò la Repubblica nel 1949. Si stabilì che tutti i beni ecclesiastici divenissero proprietà nazionale. Al fine di proteggere i confini dalle truppe francesi, austriache, spagnole e napoletane fu nominato il triumvirato di G. Mazzini, C. Armellini e A. Saffi, cui vennero conferiti poteri illimitati. Ciò nonostante, l’Assemblea decise la resa, proclamando ugualmente la Costituzione. Successivamente iniziò l’opera di restaurazione dell’autorità papale, indebolita tuttavia dalle attività cospirative di monarchici e repubblicani. Scoppiata la guerra franco-prussiana (1870), si offrì al governo italiano la possibilità di intervenire nello Stato pontificio; le truppe comandate da Cadorna furono accolte trionfalmente dalla popolazione romana. La città, ormai centro politico e amministrativo del paese, visse un crescente sviluppo urbano.
La marcia su Roma (1922) avviò il ventennio fascista, la cui apoteosi della romanità ebbe conseguenze sull’assetto urbanistico e sociale della capitale. Abbandonata dalla corte dopo la comunicazione della firma dell’armistizio con gli Anglo-Americani (1943), la città fu attaccata dai Tedeschi e cadde sotto il loro diretto dominio. Liberata dagli Anglo-Americani (1944), Roma tornò la sede del governo monarchico, e nel 1946 accolse la Costituente italiana.
Spedizioni e reso
Gli ordini possono essere soggetti a tempi di spedizione differenti.
Si prega di consultare la sezione Spedizione e Consegna nell'area clienti, per verificare i tempi di spedizione.
Se hai cambiato idea, puoi restituire un prodotto entro 14 giorni dalla consegna, inviando una richiesta al nostro Customer Service.
I prodotti restituiti non devono essere stati alterati in qualsiasi modo.
I prodotti restituiti devono avere tutte le loro etichette originali e devono avere la loro confezione originale e integra, compresa la scatola originale o la busta.